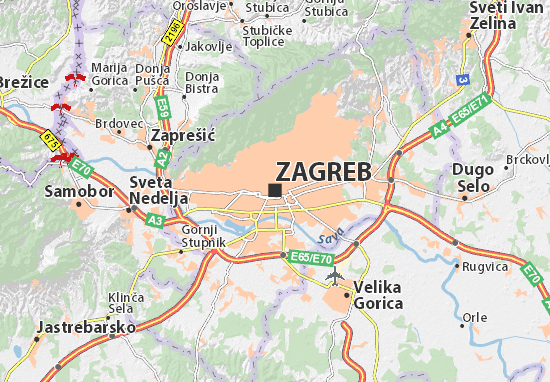La disperazione della guerra e della miseria è disegnata sul volto di un bambino di cinque, forse sei anni che sta seduto sulla strada con una fisarmonica al collo grande il doppio di lui. Il viso è ricoperto di cicatrici e sulla testa rasata porta un cappello nero da folletto.
La disperazione della guerra e della miseria è disegnata sul volto di un bambino di cinque, forse sei anni che sta seduto sulla strada con una fisarmonica al collo grande il doppio di lui. Il viso è ricoperto di cicatrici e sulla testa rasata porta un cappello nero da folletto.
Canta melodie struggenti, rese ancora più dure dalla sua voce che quasi ringhia, che sputa in faccia ai passanti tutto il dolore e la rassegnazione che si può portare addosso un bambino che forse è orfano, ma sicuramente è privo d’amore.
Quando mi avvicino, noto che non mi guarda. Neanche quando lascio scivolare due monete nella scatola davanti a lui. Guarda dietro le mie spalle, fissa il vuoto. La bocca è spalancata più del normale, i denti sono grandi e lunghi, troppo grandi per la sua età. Strizza gli occhi mentre canta, e il suo canto è un urlo, non un tentativo di creare una melodia.
È stato questo folletto disperato, più che i colpi di mitragliatrice ancora visibili sui muri dei palazzi e i tetti bombardati delle case, a farmi capire cos’era Sarajevo fino a qualche anno fa. Gli altri fanno finta che nulla sia successo, escono per strada e si infilano in uno dei tanti locali del centro, dove la musica è alta e ti fa scordare tutto. E forse è meglio così.